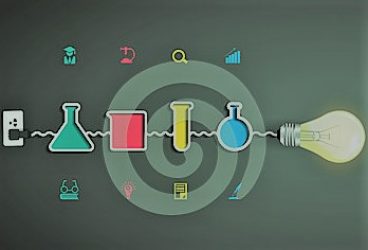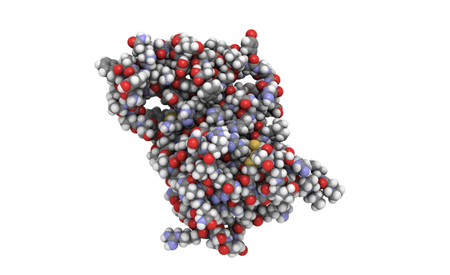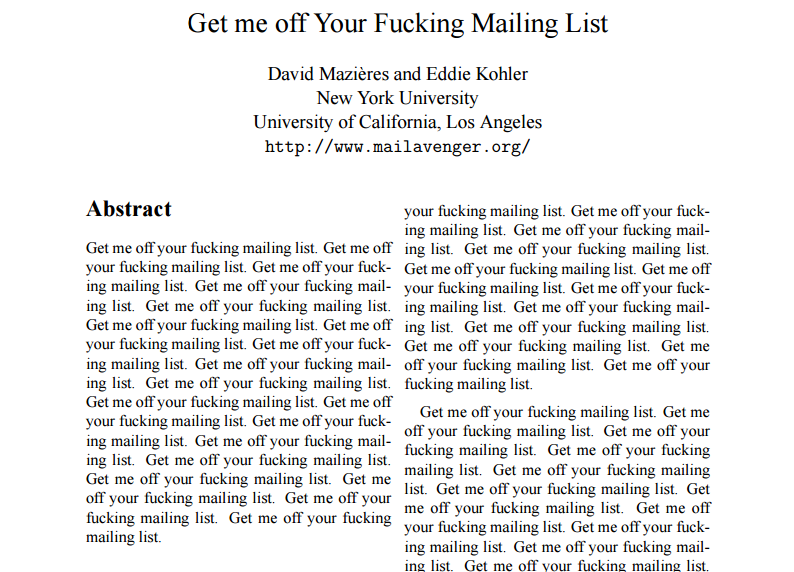Cosa c’entrano i paracadute con il metodo scientifico?
Paracadute: come recita il vocabolario Treccani, dispositivo che ha lo scopo di ridurre la velocità di caduta di un grave ad esso vincolato.
ll metodo scientifico si basa sull’osservazione dei fenomeni, sulla loro ripetibilità e riproducibilità. La ripetibilità si riferisce alla condizione per cui lo stesso laboratorio è in grado di rifare gli stessi esperimenti sempre nelle stesse condizioni. La riproducibilità è quella situazione per cui laboratori differenti sparsi per il mondo sono in grado di riprodurre gli stessi esperimenti utilizzando condizioni identiche. Ripetibilità e riproducibilità sono condizioni essenziali perché una ipotesi possa essere formulata e un modello in grado di spiegare l’osservato possa essere elaborato.
In campo chimico non è difficile riprodurre un esperimento ammesso che si abbiano fondi a sufficienza per attrezzare un laboratorio nel modo necessario. Per esempio, con pochi euro si possono comprare dei sali, acqua bidistillata, un viscosimetro. Si possono preparare delle soluzioni a concentrazione variabile dei diversi sali e se ne può misurare la viscosità. Il buon senso ci dice che all’aumentare della concentrazione aumenta anche la viscosità. Tuttavia, chi si occupa di scienza sa benissimo che il “buon senso” può essere fallace. Per questo motivo, per evitare i pregiudizi di conferma di cui ho già parlato nei riferimenti [1, 2], si possono far misurare le viscosità a ricercatori che non sanno di che tipo di soluzione stanno facendo l’analisi. Che so, una decina di soluzioni a concentrazioni differenti di sali differenti si possono conferire ad un ricercatore, un’altra decina di soluzioni diverse ad un altro ricercatore e così via di seguito. Si raccolgono le misure sperimentali e se ne fa una analisi. Ne viene che la variazione di viscosità varia in positivo (aumento) o in negativo (diminuzione) a seconda della natura del sale preso in considerazione. Tanto per fare un esempio banale, l’aumento di concentrazione del cloruro di sodio (NaCl) comporta un aumento della viscosità. Al contrario, nelle stesse condizioni, cambiando il sodio col potassio (quindi cambiando sale ed usando KCl, invece che NaCl), si osserva una diminuzione della viscosità. Non sto qui a spiegare perché. Il mio intento è altro. Questo esempio mi serve solo per far capire che se tutti i laboratori in giro per il mondo si attrezzano con le stesse strumentazioni e fanno esperimenti con le modalità descritte, sono in grado di osservare sempre lo stesso comportamento delle diverse soluzioni saline.
Il paracadute entra in capo: nel settore medico le cose non sono così semplici!
Supponiamo di voler stabilire l’efficacia di un farmaco antitumorale. Un esperimento ben progettato dovrebbe prevedere un certo numero di persone che abbiano quel tipo di tumore. Questo insieme dovrebbe essere diviso in due gruppi, per esempio gruppo A e gruppo B. Il farmaco antitumorale dovrebbe essere somministrato in modo casuale agli individui dei due gruppi. Diciamo che al gruppo A si potrebbe somministrare il farmaco, mentre al gruppo B si potrebbe somministrare un placebo. Gli individui dei due gruppi non sanno cosa assumono. I medici addetti ai controlli sperimentali non sanno cosa stanno somministrando. Un esperimento di questo tipo, simile a quello descritto sopra, si chiama “in doppio cieco” perché nessuno dei protagonisti sa cosa sta assumendo o prescrivendo. Questa tipologia di esperimenti è utile perché, come nel caso chimico già illustrato, impedisce che i risultati sperimentali risentano dei pregiudizi di conferma [1, 2]. In campo medico, tuttavia, questa tipologia sperimentale ha delle implicazioni etiche e morali insormontabili. Dal momento che gli individui di entrambi i gruppi sono affetti da tumore, in che modo si deve decidere quale dei soggetti è destinato a sicura morte? In altre parole chi decide e come fa a decidere quale delle persone coinvolte nell’esperimento deve assumere il placebo e, per questo, è destinata ad una morte molto probabile?
Un esperimento anche se ben progettato non è sempre fattibile sotto l’aspetto tecnico.
Un paradosso del genere è stato evidenziato in modo comico da due ricercatori britannici che hanno deciso di fare una meta-analisi dei lavori condotti in doppio cieco per la valutazione dell’efficienza dei paracadute nei lanci dagli aerei [3]. Il lavoro è stato pubblicato nel 2003 dal Biomedical Journal, una rivista medica abbastanza autorevole e famosa per la pubblicazione di paradossi come quello che sto descrivendo. Gli autori affermano che:
“Our search strategy did not find any randomised controlled trials of the parachute”
In altre parole, non sono stati in grado di trovare in letteratura alcun lavoro in doppio cieco in grado di poter affermare con certezza scientifica che l’uso del paracadute è fondamentale per salvarsi la vita in un lancio aereo da 5000 m o più. In effetti, gli autori suggeriscono che, per poter affermare che il paracadute è utile, si dovrebbe condurre un esperimento selezionando un certo numero di persone da suddividere in due sottogruppi: sottogruppo A e sottogruppo B. Ad ognuna delle persone dei due sottogruppi, gli addetti alla distribuzione dei paracadute devono consegnare uno zaino. Gli addetti alla distribuzione non sanno cosa contengono gli zaini che distribuiscono: possono contenere oppure no il paracadute; ognuna delle persone che riceve lo zaino non sa cosa esso contenga. Entrambi i sottogruppi vengono imbarcati e portati ad una certa altezza; da lì si devono lanciare nel vuoto. Se si osserva che tutti quelli che hanno lo zaino col paracadute sopravvivono, mentre gli altri no, si può concludere, con ragionevole certezza, che il paracadute ha una certa efficacia, fino a prova contraria, nel salvare le vite umane.
Nelle loro conclusioni, in breve, gli autori affermano:
“As with many interventions intended to prevent ill health, the effectiveness of parachutes has not been subjected to rigorous evaluation by using randomised controlled trials. Advocates of evidence based medicine have criticised the adoption of interventions evaluated by using only observational data. We think that everyone might benefit if the most radical protagonists of evidence based medicine organised and participated in a double blind, randomised, placebo controlled, crossover trial of the parachute”.
In altre parole, i sostenitori compulsivi di esperimenti in doppio cieco in campo medico, quando esperimenti del genere sono insostenibili per motivi etici e morali, si dovrebbero offrire volontari per studi in doppio cieco sulla efficienza dei paracadute nei lanci aerei.
Morale della storia: ci sono situazioni in cui gli esperimenti randomizzati in doppio cieco è meglio non farli oppure è meglio farli non su esseri umani; la sopravvivenza della specie, in mancanza di alternative efficaci, si può assicurare tramite la sperimentazione animale.
Riferimenti:
[1] https://www.facebook.com/RinoConte1967/posts/1920705241484336:0
[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC300808/pdf/32701459.pdf
Ringraziamenti:
Si ringrazia il Dr. Arturo Di Girolamo per aver accennato agli esperimenti in doppio cieco sui paracadute nella sua lezione sull’utilità dei vaccini tenuta il 10 Febbraio 2017 presso il Caffè dei Libri di Bassano del Grappa. La lezione è a questo link: https://www.facebook.com/RinoConte1967/videos/1930788107142716/