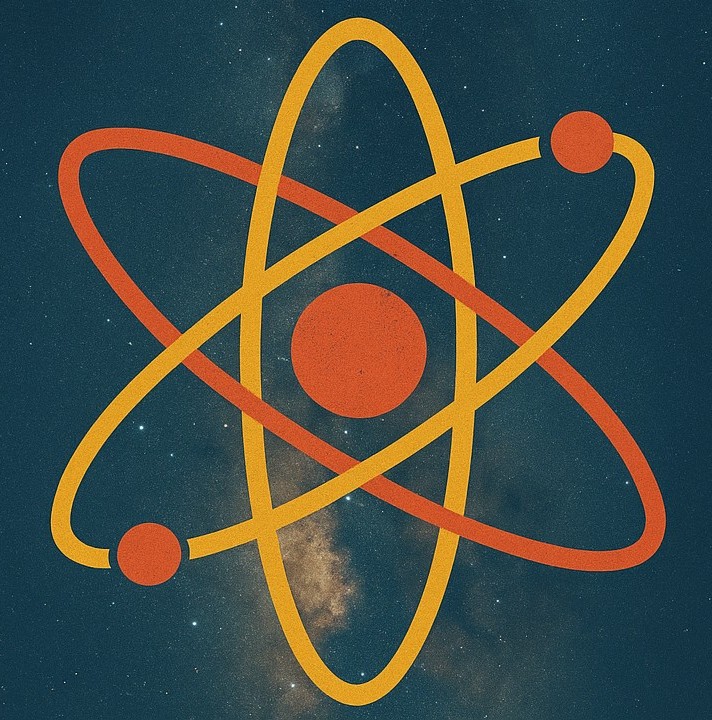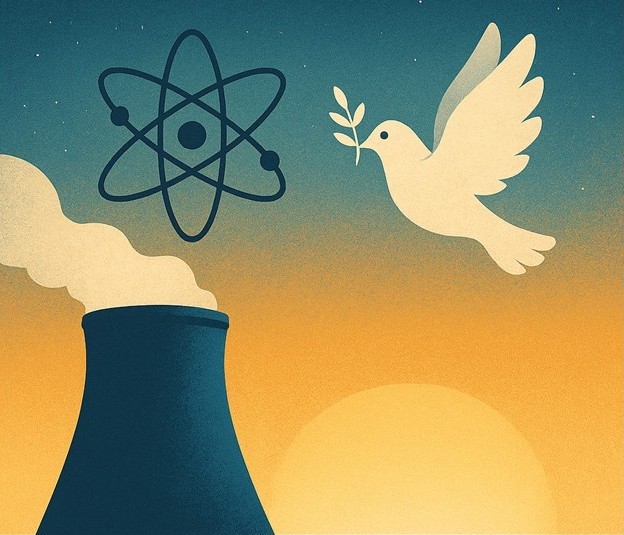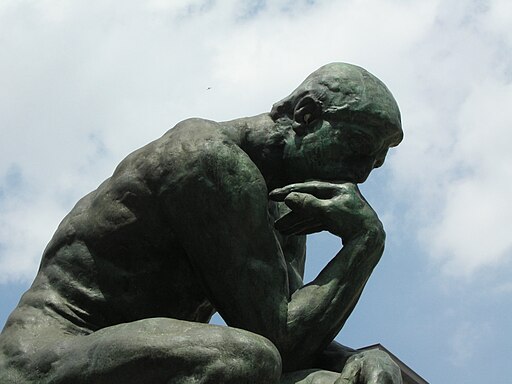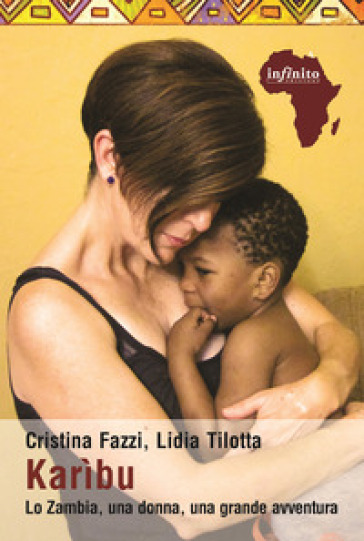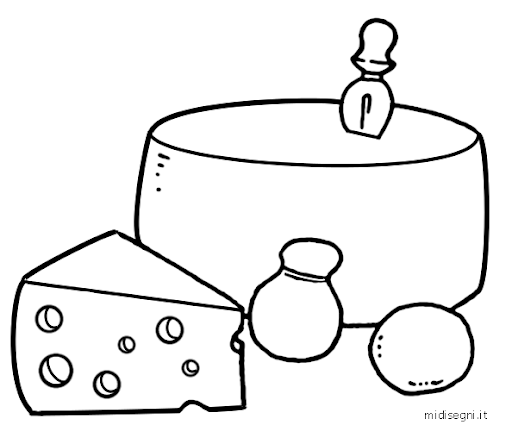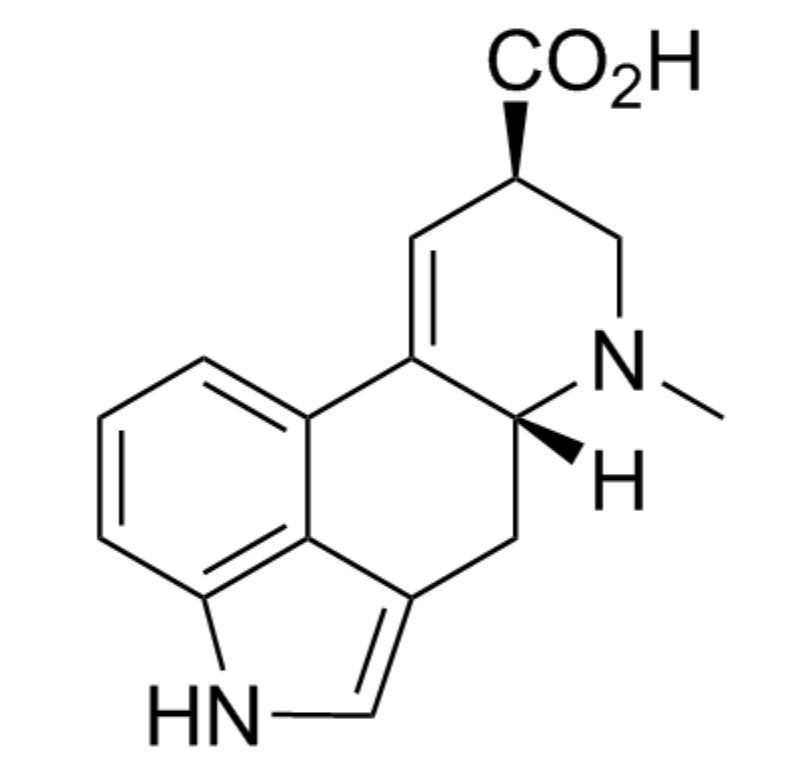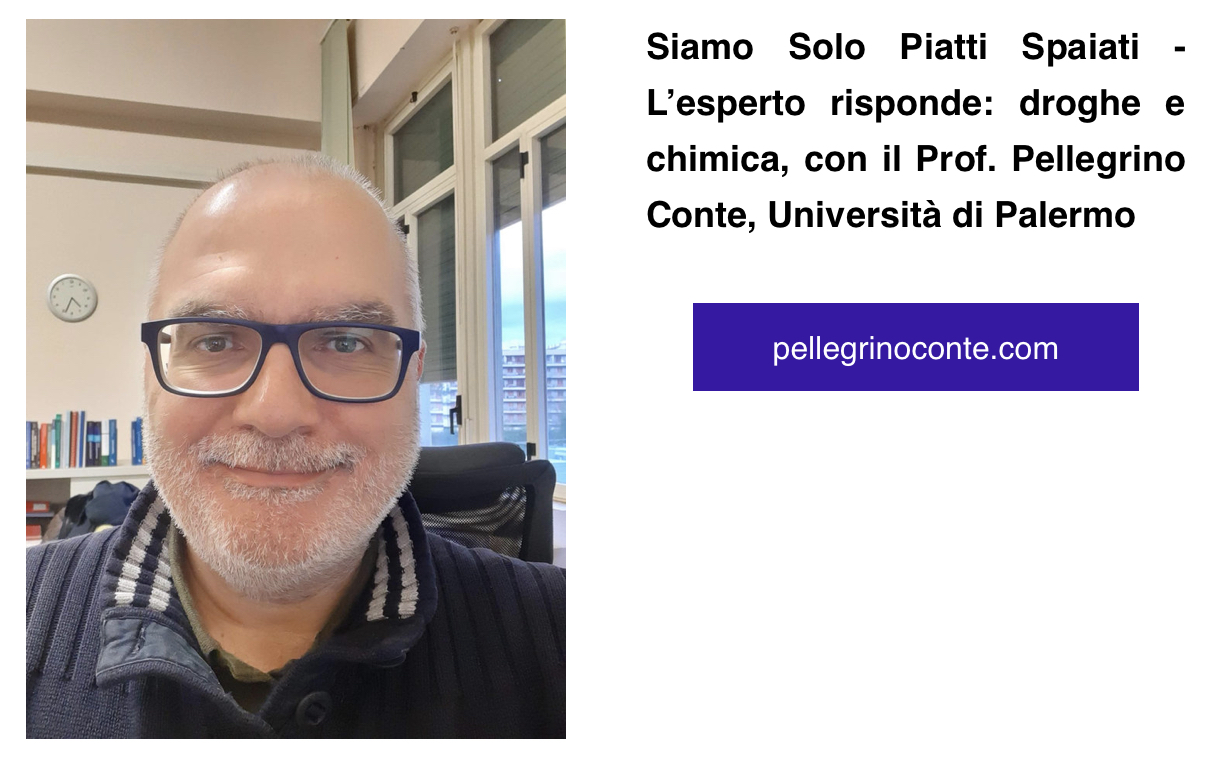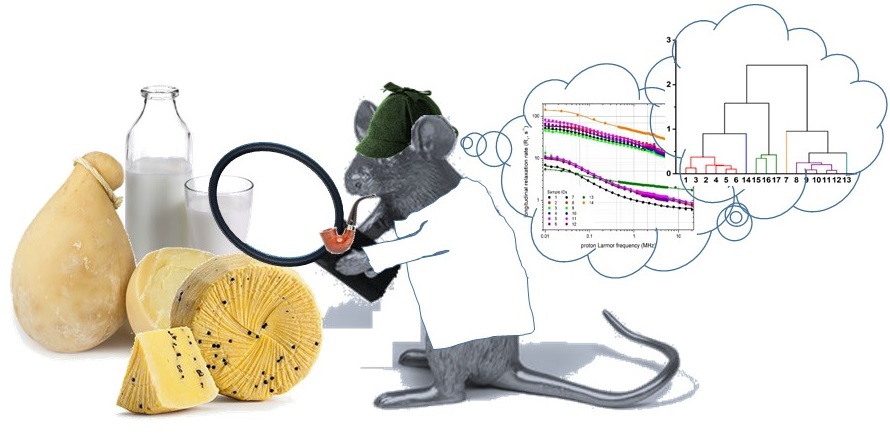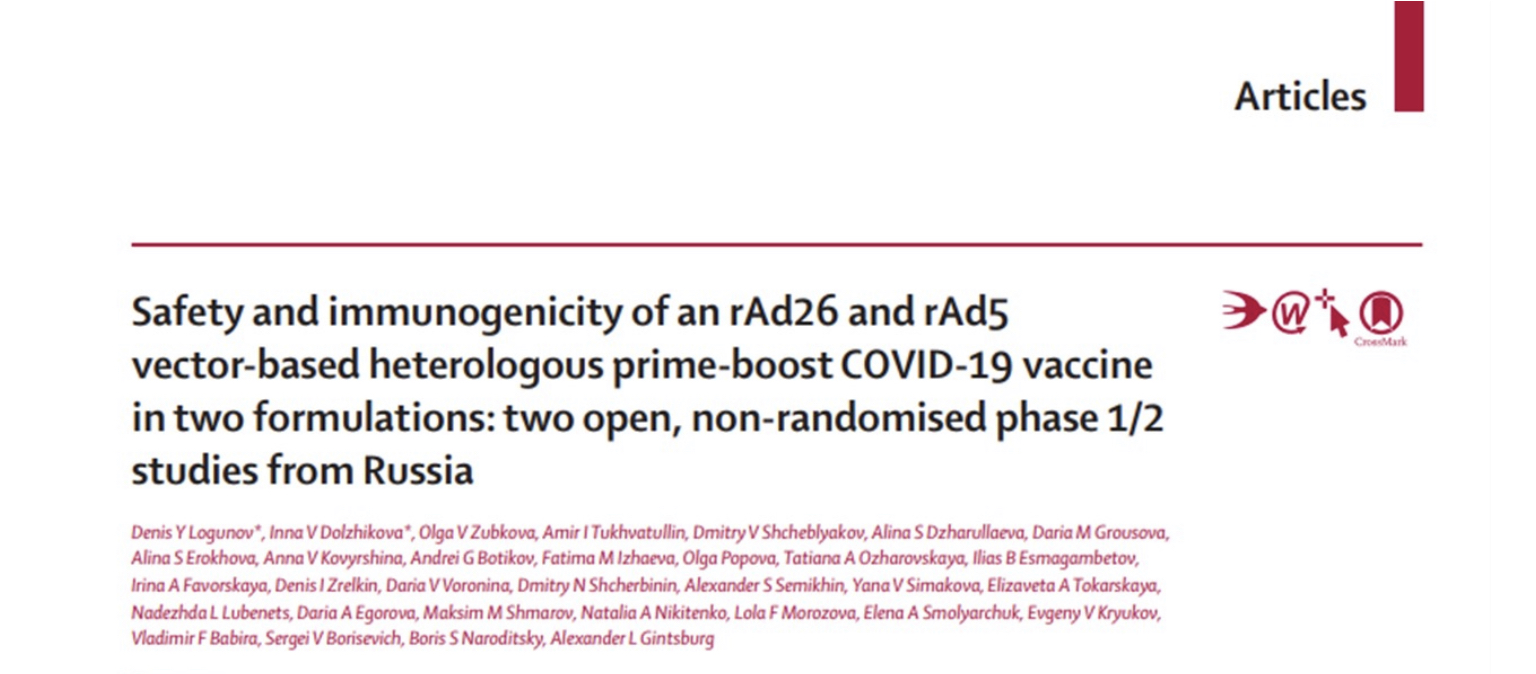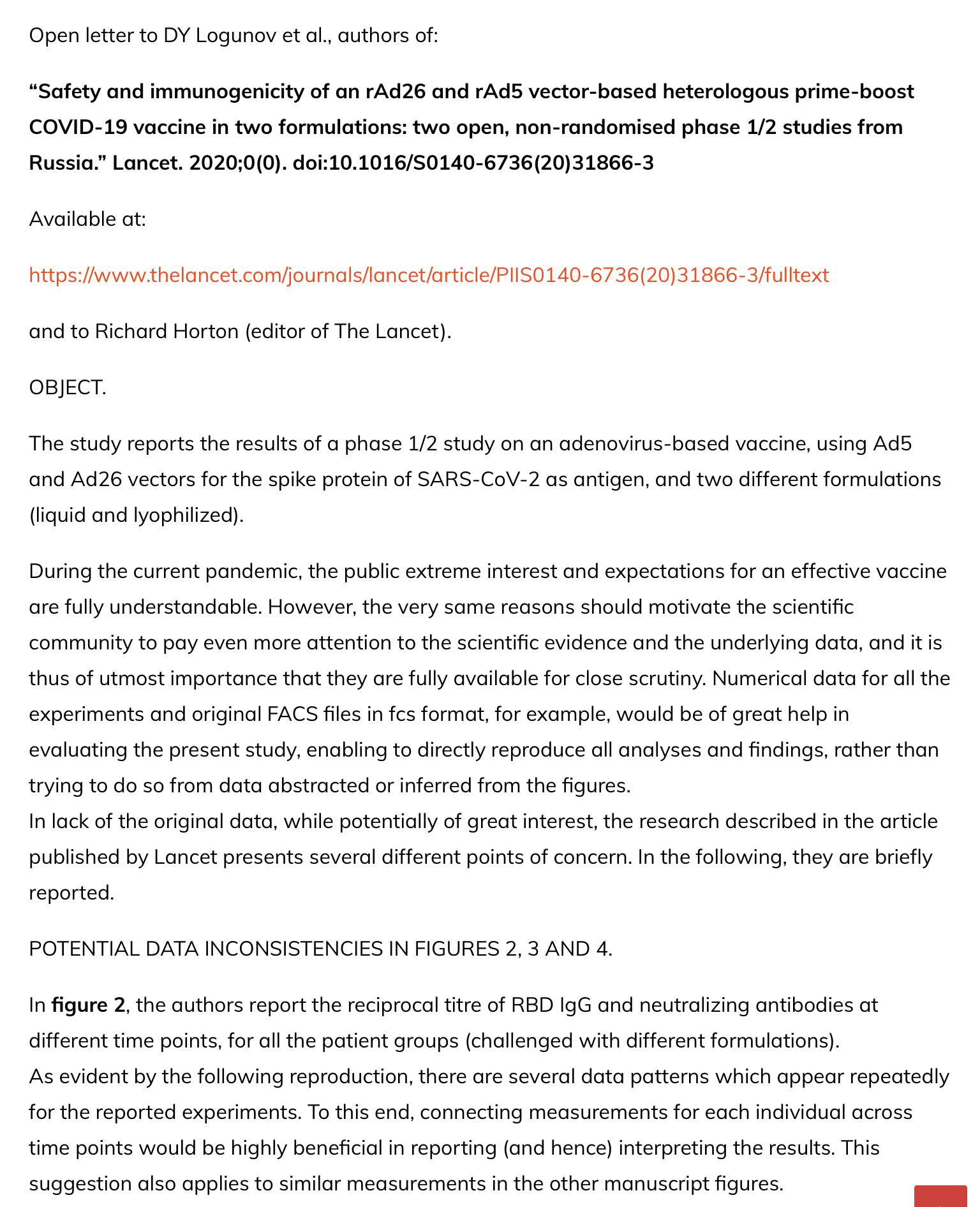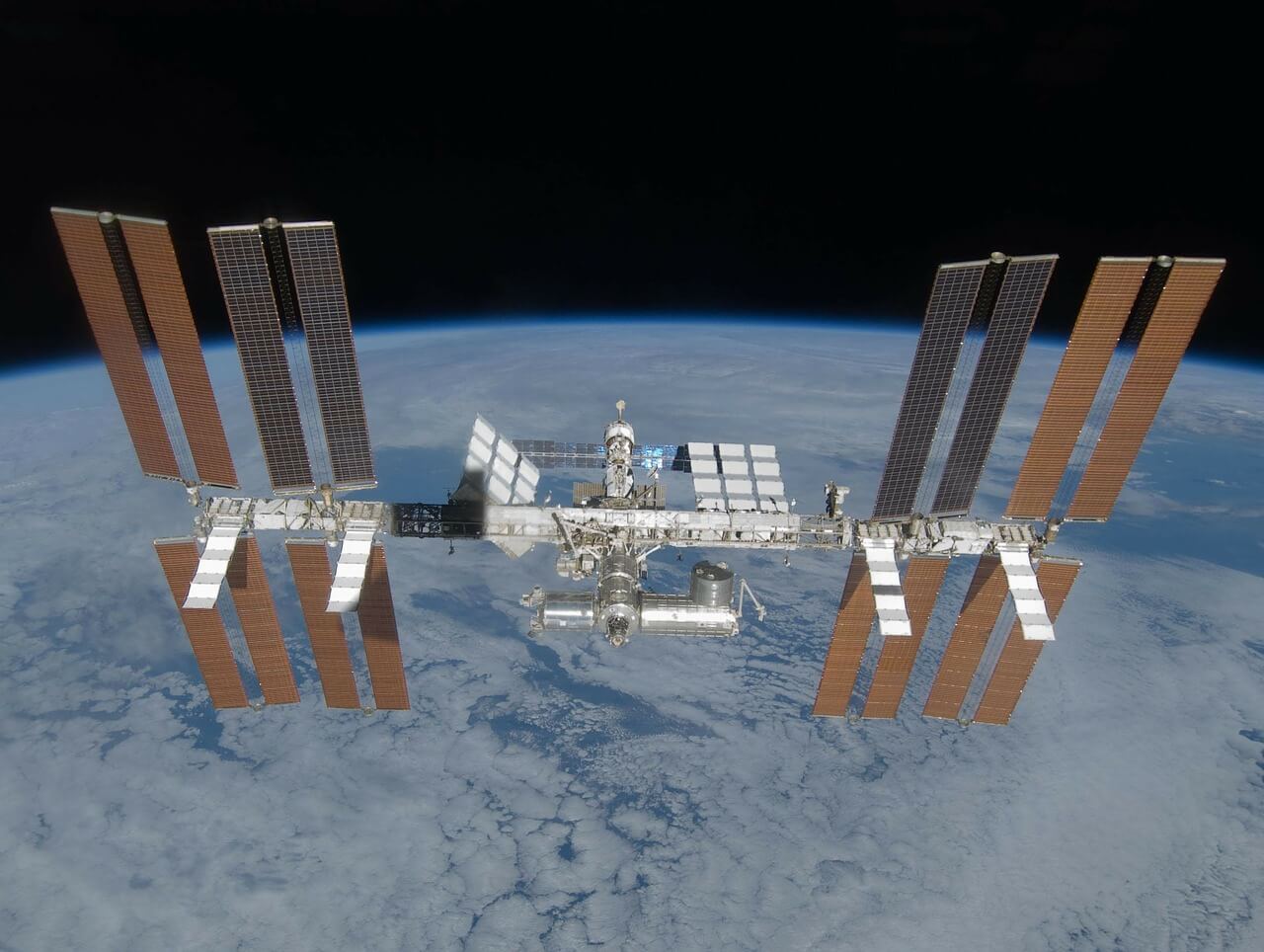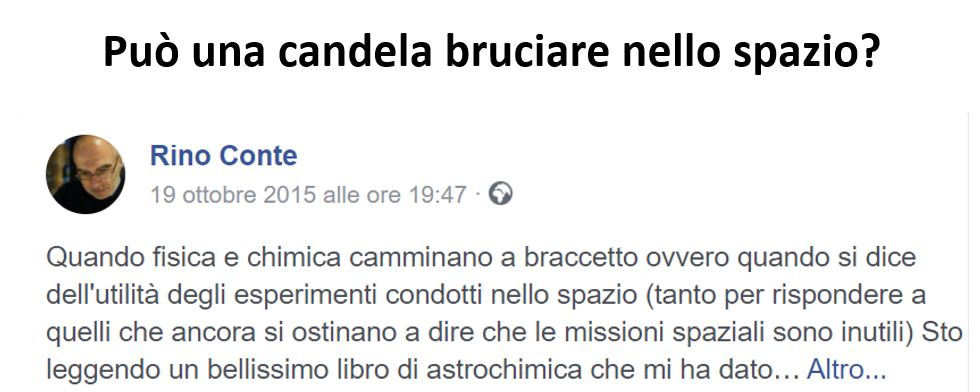Come ho già avuto modo di scrivere qualche tempo fa, non aggiorno il blog con la frequenza di un tempo perché molti degli argomenti che oggi vanno di moda sono già stati commentati da me negli anni passati. Si pensi, per esempio, alla polemica «naturale=buono» di cui ho parlato qui e qui, oppure al periodico successo di cose come il Dr. Bestiale di cui ho già parlato qui, o, ancora, l’intolleranza al lattosio di cui ho scritto qui e qui, per non parlare, poi, dell’enorme numero di articoli che ho scritto in merito all’omeopatia (qui) o altre pseudo scienze come l’agricoltura biodinamica (qui). Capirete, quindi, che ritornare sempre sugli stessi argomenti, perché periodicamente di moda, è alquanto noioso. Mi annoio io a scriverne e annoio voi che, sulla base della vostra stima nei miei confronti, siete “costretti” a leggere sempre le stesse cose, magari scritte con parole diverse. Tuttavia, di tanto in tanto, ci sono degli argomenti che ancora mi colpiscono e che mi lasciano perplesso soprattutto quando a scriverne/parlarne sono persone che si dicono amanti della scienza.
Ma veniamo al punto.
I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it
Gli “amanti della scienza” molto spesso riportano nelle loro lettere, nei loro siti o ovunque sia possibile la famosa massima secondo cui «non condivido la tua opinione, ma sono pronto a combattere affinché tu possa esprimerla liberamente» attribuendola nientepopodimenoché a Voltaire. Queste persone, per lo più pseudo scienziati, usano questo aforisma per rimarcare la differenza del loro modo di pensare rispetto a quello degli scienziati che apparterrebbero, secondo loro, ad una casta di tipo sacerdotale chiusa e poco avvezza ai cambiamenti. Gli scienziati, in parole povere, sarebbero quelli che si opporrebbero allo sviluppo culturale di certe discipline (o addirittura del paese) chiudendosi a riccio nei confronti di idee innovative in grado di apportare benefici in ogni ambito dello scibile.
Cominciamo con lo stabilire che da nessuna parte nell’opera di Voltaire è riportata la frase anzidetta. Questa fu scritta virgolettata in “The friends of Voltaire” nel 1903 da Evelyn Beatrice Hall sotto lo pseudonimo di Stephen G. Tallentyre. Quindi, Voltaire, che ha scritto il famoso “Trattato sulla tolleranza”, non si è mai sognato di dire quelle cose riportate come sue. Lo stesso Sandro Pertini, in un suo discorso, cadde nell’equivoco di attribuire a Voltaire la massima su menzionata (qui). Purtroppo, usare in modo strumentale frasi ad effetto attribuendole a grandi menti per esaltarne la significatività è uno sport molto attuale. Ricordo che nel 1938 in Italia furono promulgate le leggi razziali. Se dovessimo prendere alla lettera ciò che viene indicato come l’aforisma massimo della libertà di espressione, dovremmo concludere che, seppure le leggi razziali furono quanto di più bieco una mente umana avesse potuto concepire, gli individui che le promulgarono avevano tutto il diritto di farlo e di seguire le condotte opportune per realizzarle. Ma ciò contraddice sia l’operato di Pertini che si è battuto, rischiando più volte la vita, contro il fascismo – corrente politica responsabile delle anzidette leggi – che i principi basilari di tutti i trattati in cui vengono stabiliti i diritti inalienabili degli individui intesi come persone umane. Da questa breve disamina, quindi, ne viene che la libertà è sacrosanta (peraltro è uno dei diritti inalienabili della persona umana) ma ha dei limiti entro cui essa può essere esercitata.
Adesso, però, come al mio solito, sto andando un po’ per la tangente.
Libertà di parola ed opinioni
Ritorniamo all’aspetto scientifico legato all’aforisma incorrettamente attribuito a Voltaire. Secondo gli pseudo scienziati, il diritto di parola e di opinione è sacrosanto. Ma io sono più che d’accordo. Il problema è che una cosa è il diritto di parola e opinione in ambito politico (sempre entro i limiti dettati dal rispetto per i diritti umani inalienabili), altro è il diritto di parola e opinione in ambito scientifico. Tradotto in parole molto più semplici: in ambito scientifico, una cosa è la libertà di parola, altro sono le parole in libertà.
Come ho avuto più volte il modo di evidenziare (per esempio qui), la Scienza (la S – in maiuscolo – non è casuale) è un complesso corpo di conoscenze che richiede lo sviluppo di competenze che si raggiungono con anni di studi e sacrifici. L’idea dello scienziato come il Don Chisciotte di turno che va per la propria strada all’inseguimento di una intuizione illuminante ma contraria al pensiero scientifico corrente è da film hollywoodiano. Avete mai visto un film – nato per l’intrattenimento – in cui si pone l’accento sul tempo passato da uno studioso a leggere e capire le cose invece che su scene di azione più o meno movimentate? Penso proprio di no. E volete sapere perché? Lo studio è noioso. A chi volete che interessi vedere uno che resta seduto al tavolo a sfogliare libri su libri per giorni interi solo per capire questa o quella formuletta? Il film deve intrattenere, deve tener legato l’utente/spettatore alla sedia ed attrarlo. Se l’utente/spettatore si annoia incomincia il passaparola negativo per cui altri utenti/spettatori non andranno a vedere il film con evidenti danni economici. Ed allora molto meglio inventarsi che Einstein era una “rapa” in matematica (non è assolutamente vero) e che, nonostante questo, sia stato in grado di vincere il premio Nobel; meglio inventarsi che Galileo Galilei ha combattuto contro il sistema imperante ed ha perso, invece che spiegare che l’eliocentrismo era già in voga e che Galilei è stato osteggiato dalla chiesa – quindi da una setta religiosa – che vedeva nelle sue “osservazioni” qualcosa che poteva scardinare il potere temporale del Papa.
L’intuizione scientifica
L’intuizione scientifica non nasce dal nulla. Nasce, piuttosto, dall’apprendimento continuo di cose già note che vengono “sviscerate” in tutti i modi possibili. Una volta individuati i limiti delle cose note (questo si fa attraverso gli esperimenti e la loro interpretazione) viene fuori l’intuizione geniale che consente l’avanzamento delle conoscenze. In questo senso amo ripetere che alla fine dell’Ottocento si riteneva che la fisica non avesse più nulla da dire. Tutto era già stato detto e scoperto da sir Isaac Newton. Ed invece, dal paradosso del corpo nero è nata quella che oggi è conosciuta come meccanica quantistica – che ha inglobato la meccanica classica (quella di Newton, per intenderci) – che ha consentito lo sviluppo di nuove tecnologie come la TAC (Tomografia Assiale Computerizzata), la NMR (Risonanza Magnetica Nucleare) fino ad arrivare ai computer quantistici. Del resto fu Bernardo di Chartres, intorno alla prima metà del 1100, a dire qualcosa del tipo “siamo seduti sulle spalle dei giganti” intendendo che la conoscenza – scientifica o meno, dico io – può essere intesa come un castello in continua crescita in cui è possibile individuare torri alte la cui stabilità è assicurata dalle fondamenta solide, costruite da chi ci ha preceduto, e torri basse e diroccate le cui fondamenta non hanno resistito all’azione del tempo. In altre parole, se oggi siamo in grado di controllare i movimenti di Curiosity (il rover che sta analizzando il suolo di Marte) lo dobbiamo a Newton, dalla cui fisica siamo in grado di calcolare l’energia necessaria per sfuggire alla forza gravitazionale terrestre, a Marconi, che ha scoperto la trasmissione dei segnali senza fili, a tutti quei chimici che hanno elaborato le tecniche analitiche in grado di campionare e analizzare i suoli etc. etc. etc.
Il dubbio
Un corollario interessante all’aforisma scorrettamente attribuito a Voltaire è che bisogna essere tolleranti, anzi aperti alla discussione, con chiunque avanzi dubbi – più che legittimi – su tutto quanto riguarda la scienza. Del resto, l’avanzamento delle conoscenze scientifiche non si basa sui dubbi? Il problema qui è capire cosa si intende per “dubbio”.
Quando sono in aula per i miei corsi mi trovo spessissimo in presenza di dubbi. A parte quelli personali legati all’efficienza della mia esposizione, i dubbi principali sono quelli dei miei studenti che possono non aver capito qualcosa che ho detto o che possono avere domande per correlare ciò che sanno a ciò che ho esposto. Si tratta, quindi, di dubbi – quelli degli studenti – che servono per chiarire concetti noti in modo tale da permetterne un immagazzinamento migliore così da poterli utilizzare nei momenti opportuni. Per quanto riguarda i miei dubbi, si tratta di domande che mi faccio prima, durante e dopo la lezione per capire quanto sono stato efficiente nell’esposizione. Non sempre lo sono perché dipende dai momenti umorali in cui mi trovo. Quando me ne rendo conto ripeto la lezione cercando di essere più chiaro. Quindi, nel caso del rapporto asimmetrico docente-studenti, i dubbi servono per crescere e migliorare. Io imparo dagli studenti a spiegare meglio, ovvero cerco di migliorare come docente, mentre gli studenti imparano da me cose che serviranno loro nelle future esperienze da professionisti.
Un discorso analogo vale se faccio una domanda al mio elettricista o al mio idraulico. In questo caso io faccio il discente, loro sono i docenti.
Ma cosa succede se la tolleranza in merito alla libertà di espressione e di opinioni viene invocata da qualcuno che, non avendo competenze in quel campo, volesse obiettare, per esempio, che la Terra è piatta? Si tratta veramente di un dubbio? Ovviamente, no! Questo non è un dubbio. Questa è semplicemente ignoranza. La persona che volesse intavolare una discussione sulla geoidicità del nostro pianeta è solo uno/a che ci fa perdere tempo. Evidentemente ha saltato tutte le lezioni (dalle elementari alle superiori) in cui si è discusso e si sono portate prove in merito. Lo stesso è valido quando a evocare dubbi sulla validità ed efficacia dei vaccini è mamminapancina86. In realtà, nella mia vita mi è capitato che ad avere dubbi sui vaccini non fossero solo persone ignoranti (nel senso etimologico del termine), ma anche professionisti che hanno una cultura e una preparazione che li pone agli apici del loro campo. Ma di questo accennerò fra poche righe. In generale, si tratta di ignoranza pura e semplice, che pone queste persone al livello di studenti che devono ancora imparare e a cui è utile dare spiegazioni semplici, sempre che si rendano conto del rapporto di asimmetria tra loro e chi ha studiato e “perso tempo” per approfondire l’argomento su cui loro hanno espresso dubbi.
Il dubbio qualificato
Se possiamo prendere con ilarità i “dubbi” sulla Terra piatta, non possiamo fare altrettanto quando, invece, si parla di vaccini, di omeopatia, di agricoltura biodinamica, di negazione del riscaldamento climatico o della componente antropica legata al riscaldamento climatico. A maggior ragione quando ad avanzare tali “dubbi” non sono ciarlatani incolti, ma professionisti che hanno una formazione culturale adatta a discernere tra vero, verosimile e falso. In questo caso, come ho già scritto altrove (qui), si tratta di persone che per meri fini opportunistici – che siano economici o per esercitare un qualsiasi potere, poco importa – si comportano come quelli che prima fanno la curva e poi inseriscono i punti sperimentali. Sono persone inaffidabili. Con esse non è possibile intavolare alcuna discussione perché si arroccano su posizioni asimmetriche per cui i loro dubbi sono legittimi, mentre le prove fisiche portate da chi confuta le loro teorie astruse non sono valide.
Da tutta questa digressione ne viene che a livello scientifico quando si parla di dubbio si intende sempre il cosiddetto “dubbio qualificato”. Si tratta di un dubbio che non coinvolge tutti i possibili interlocutori, ma solo coloro che hanno una formazione culturale in comune, ovvero hanno studiato, elaborato e compreso quanto attinente a un determinato argomento. È proprio questa comprensione che consente di fare domande nel merito per ottenere risposte in grado di dirimere problemi che da soli non sarebbe possibile fare.
Conclusioni
Cosa voglio concludere con questa lunga digressione? Solo che bisogna fare attenzione a quelle persone che usano la massima falsamente attribuita a Voltaire. Queste persone, lungi dall’essere “modeste” come vorrebbero apparire mediante l’uso dell’aforisma citato, sono, in realtà, dei narcisisti che hanno mal compreso i processi che vengono seguiti per lo sviluppo scientifico e ritengono sé stessi dei geni che, pur non avendo competenze specifiche in un particolare campo, ritengono di aver diritto di parola proprio in quel settore di cui conoscono molto poco – o addirittura niente – come se fossero dei grandi luminari. Ancora oggi, a distanza di oltre quarant’anni, è ancora valido quanto tenne a scrivere Asimov nella sua rubrica “My turn” il 21 gennaio del 1980 (qui): “my ignorance is just as good as your knowledge”.
Ringraziamenti
Con questa lunga disamina spero di non avervi annoiato troppo. Tuttavia, come talvolta accade, ci sono dei momenti in cui, dopo aver letto e/o sentito certe cose, mi rimane l’amaro in bocca e sento l’esigenza di condividere in questo blog i miei pensieri. Pertanto, ringrazio tutti voi, miei lettori, per la pazienza che avete avuto nel voler leggere queste elucubrazioni e ringrazio il Dr. Michele Totta per la sua pazienza nel revisionare questo articoletto. Il Dr Totta, peraltro, è un valente divulgatore che gestisce un canale YouTube “Senza logica mal si cogita” che invito a seguire (qui).
Fonte dell’immagine di copertina
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2005_Mus%C3%A9e_Rodin_3.jpg