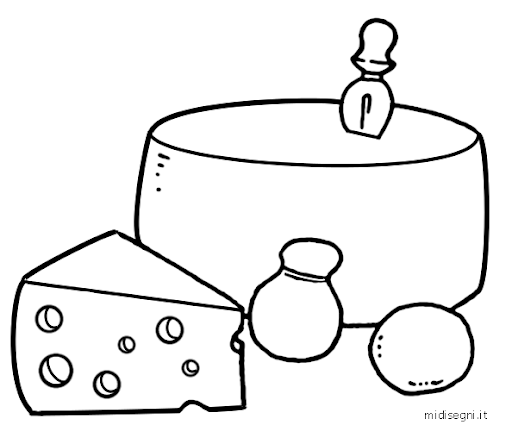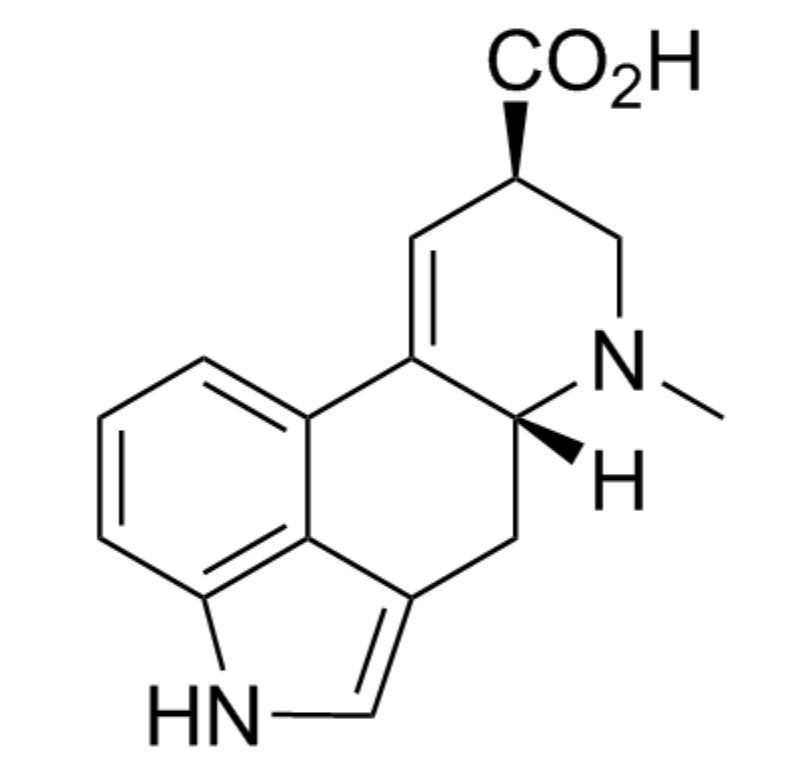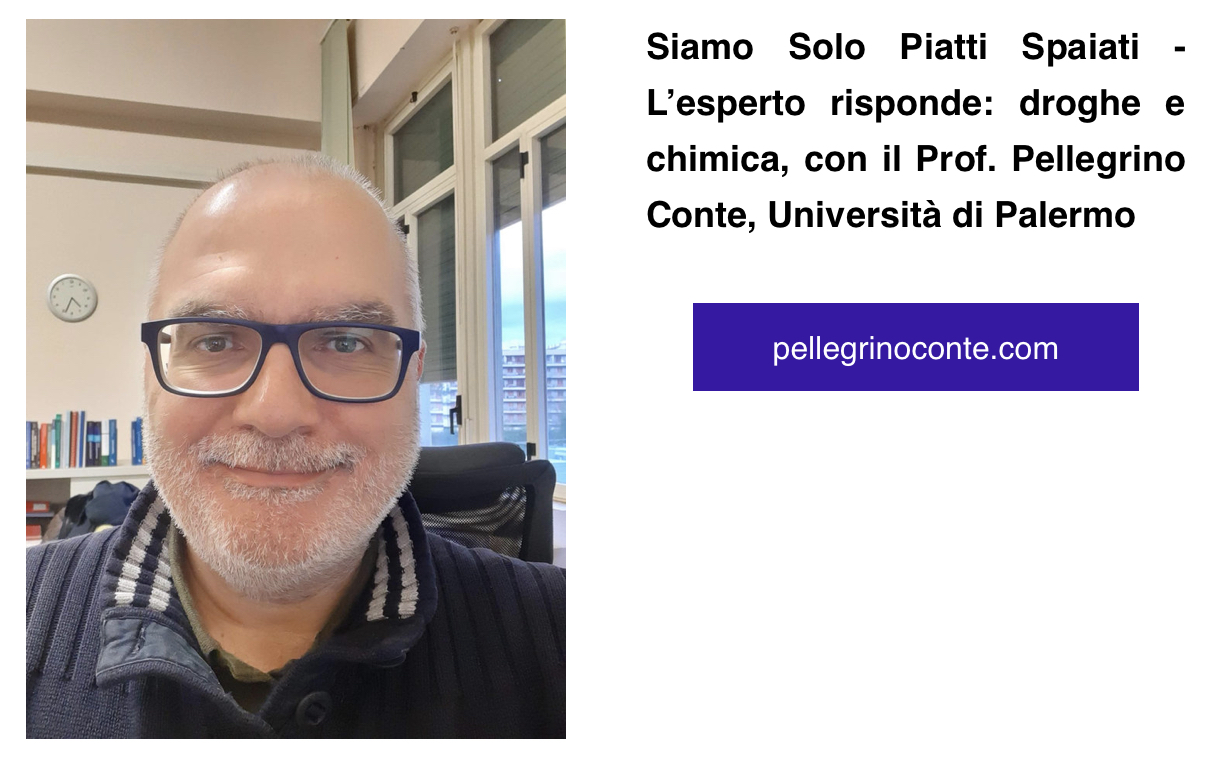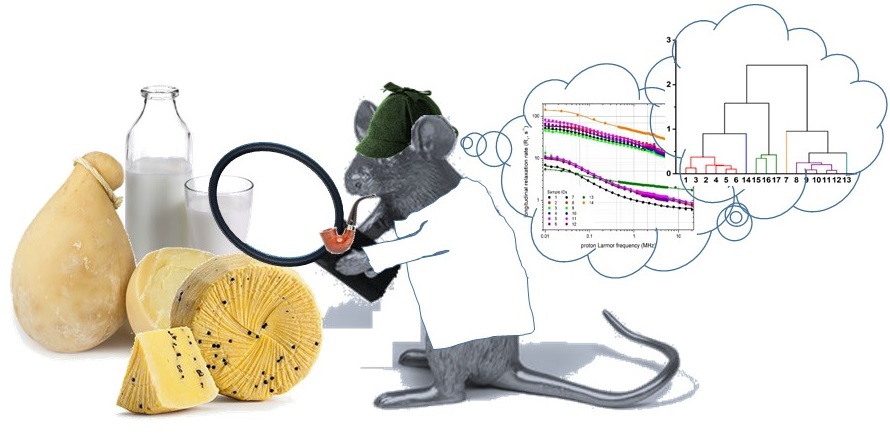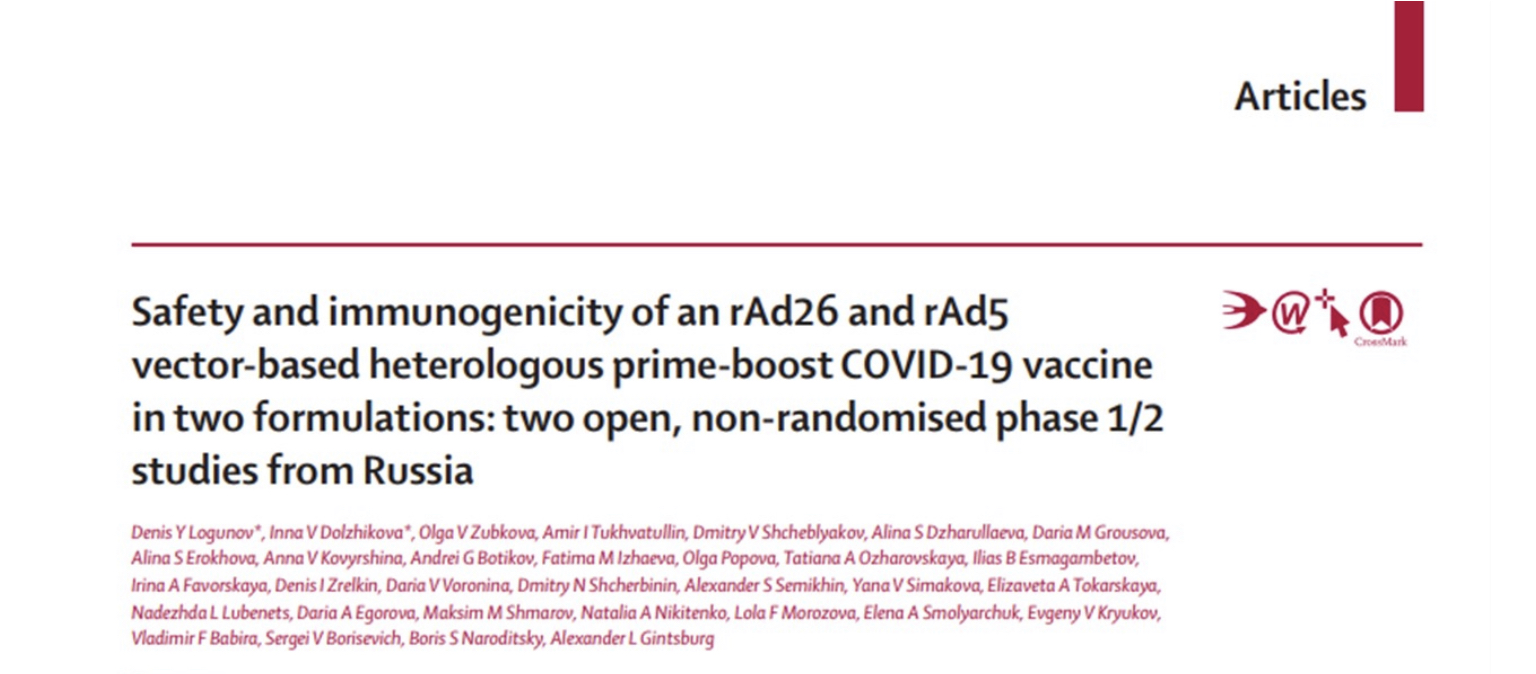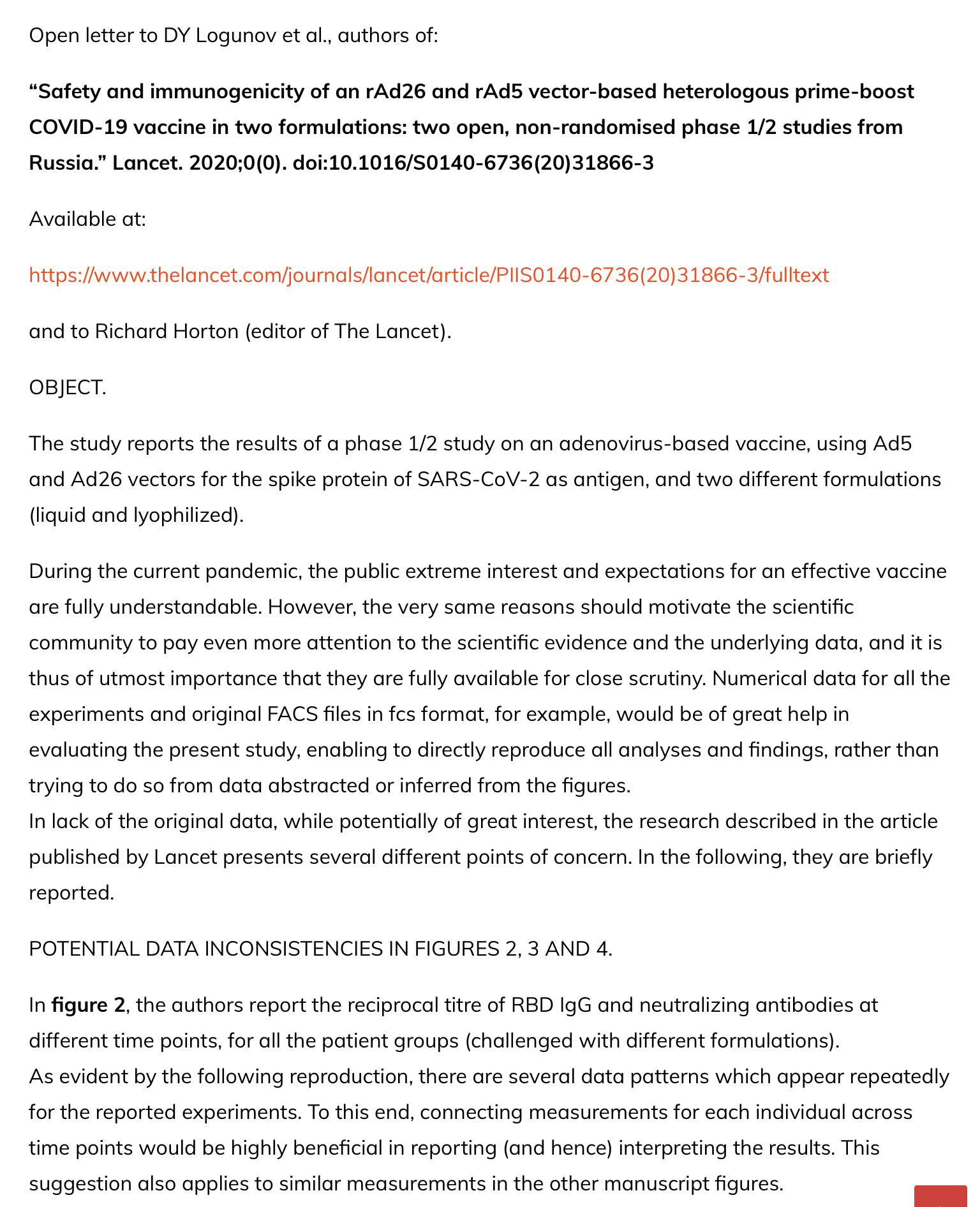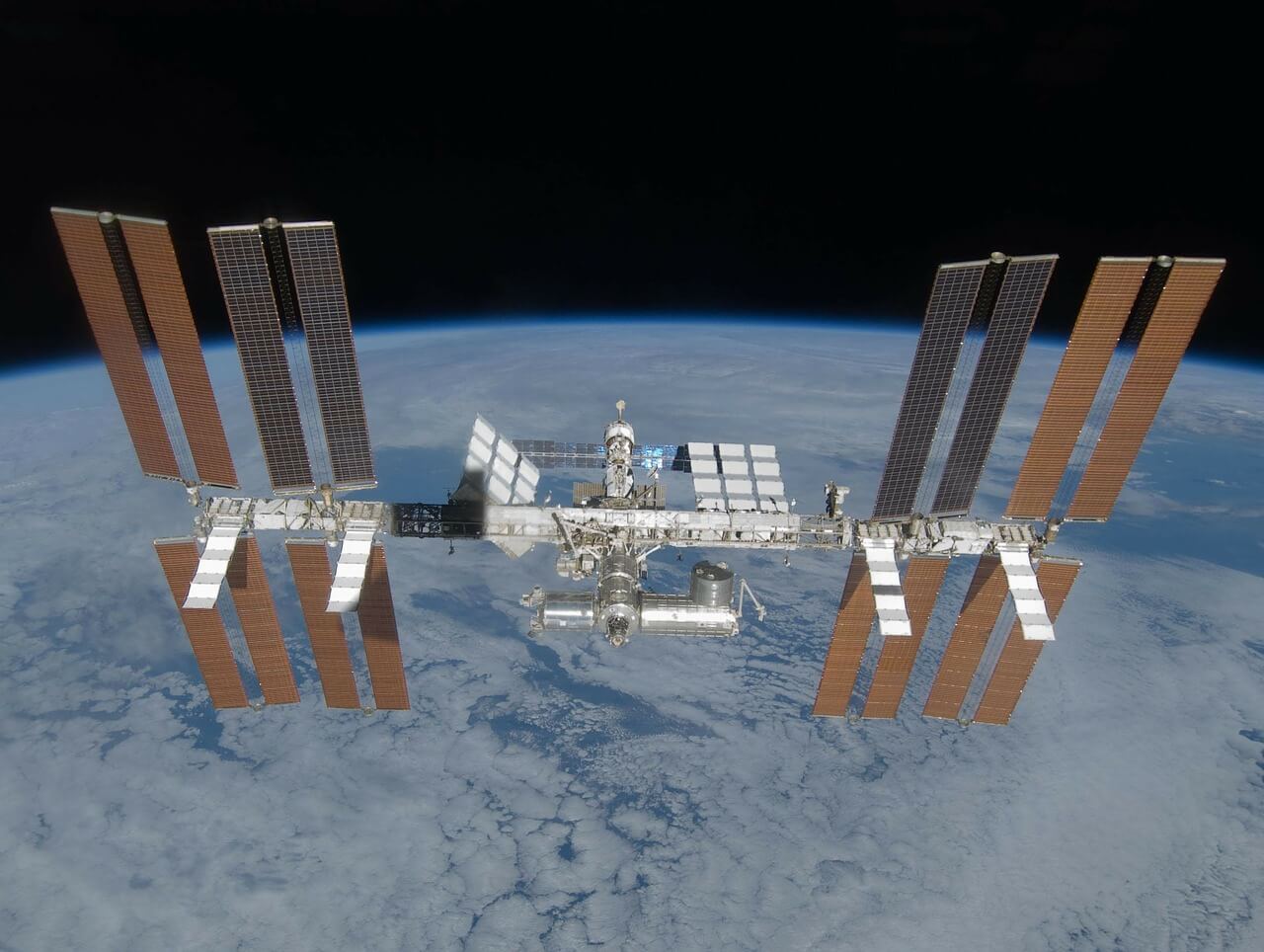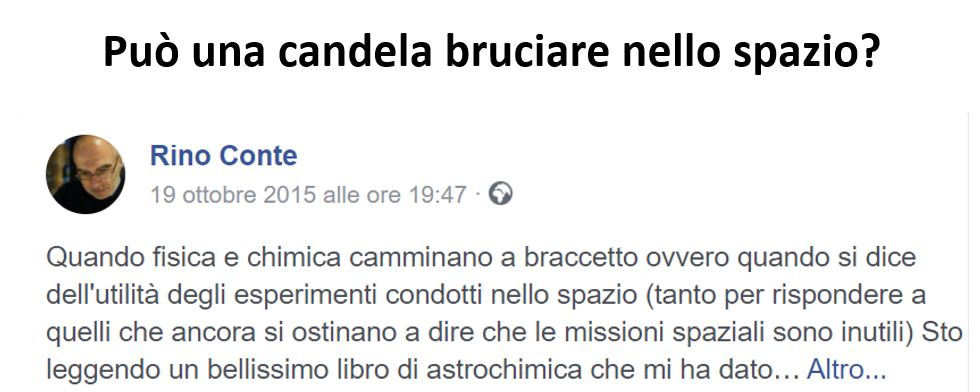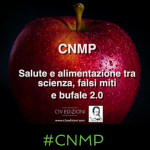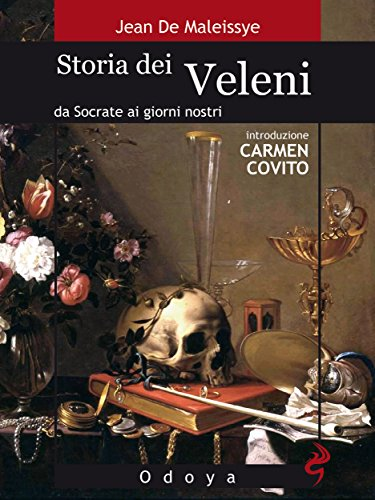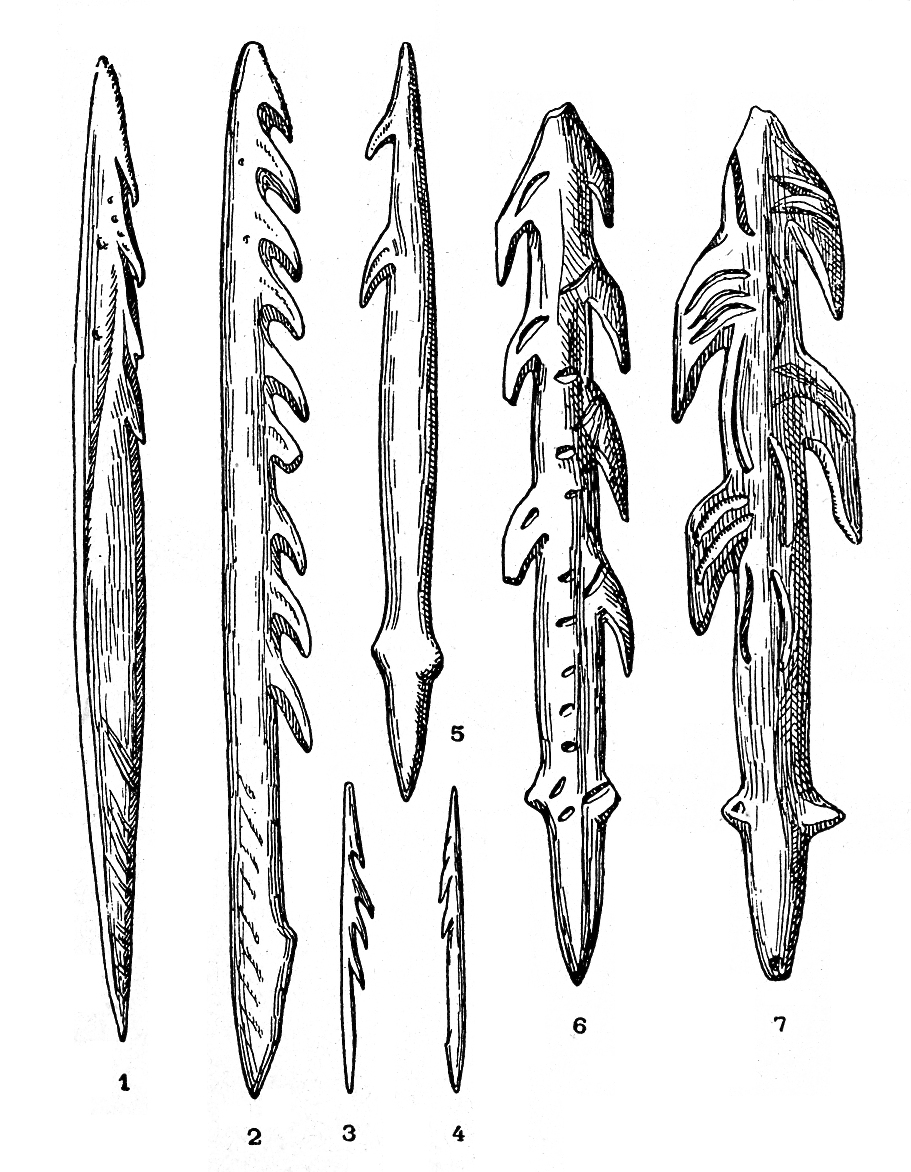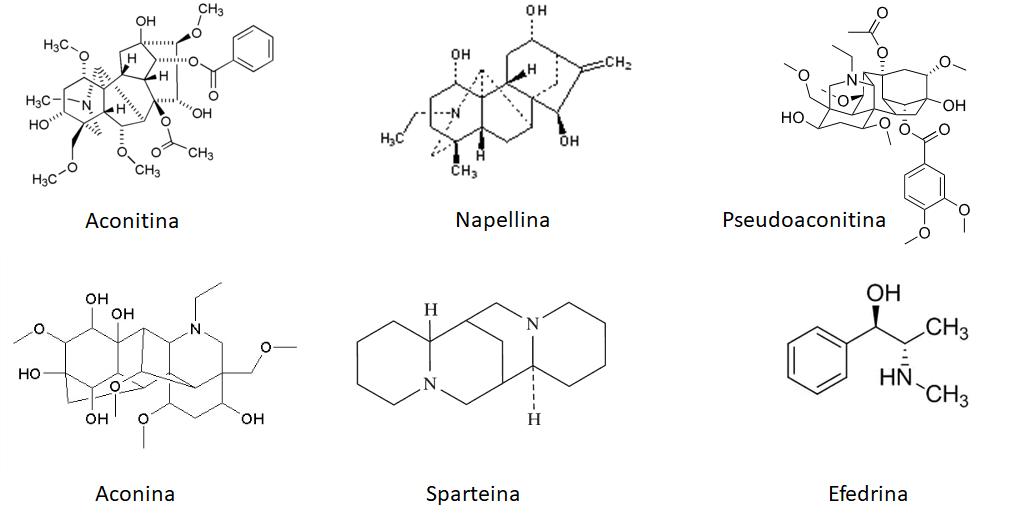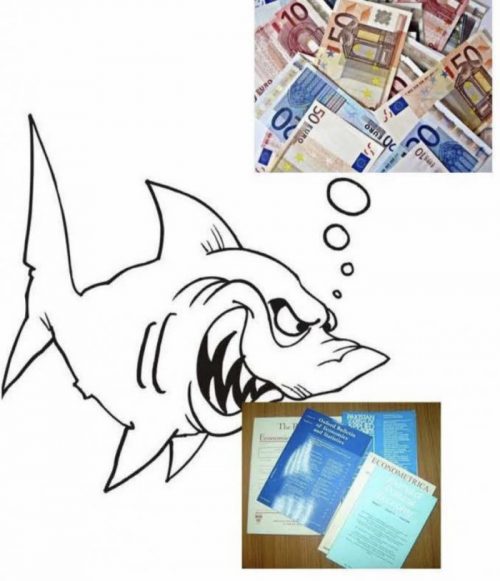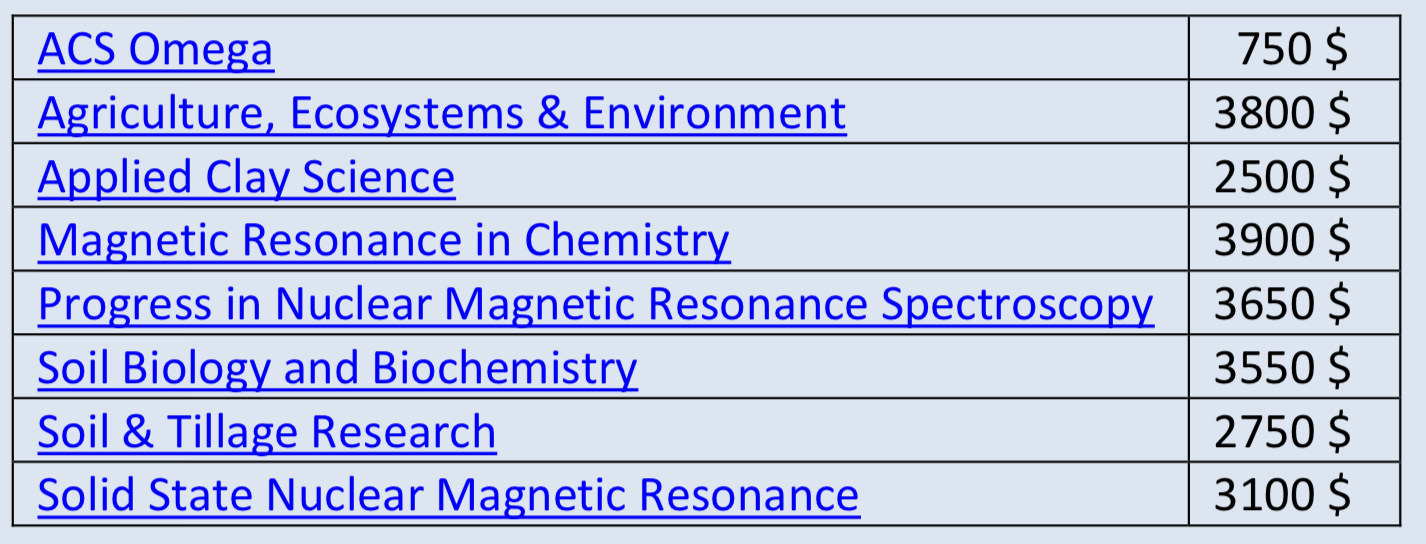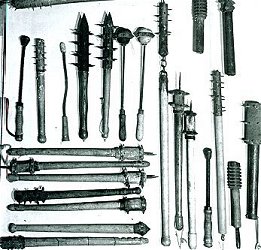Ieri sera (il 26 Giugno 2021) ho partecipato ad un interessante evento culturale a Bassano del Grappa: La Milanesiana. Si tratta di un progetto itinerante che ha raggiunto il suo ventiduesimo anno di età. Ha come oggetto un tema differente per ogni anno. Quest’anno l’evento è stato dedicato al progresso.
Benché accattivante, il tema non viene spiegato molto bene. Nel programma, che si può trovare a questo link, è scritto:
“Il tema di questa ventiduesima edizione, come quello degli ultimi anni, è stato scelto da Claudio Magris: il Progresso. Un tema già in sé denso di paradossi. Dopo quello che abbiamo vissuto possiamo ancora parlare di progresso? E possiamo farlo in modo univoco? Possiamo dire, forse, che ci sono tanti progressi, almeno quanti sono i passi indietro?”
Belle parole. Ma cos’è il progresso?
Non voglio addentrarmi in una discussione sul significato di progresso. Ciò che, in realtà, mi ha colpito e mi ha lasciato con l’amaro in bocca è stata la distinzione tra progresso scientifico e progresso culturale introdotta nei primi minuti della presentazione dell’evento ideato da Elisabetta Sgarbi. Questa distinzione mi ha fatto riflettere e mi porta a riflettere “ad alta voce” su questo blog in cui, tra le tante cose, spesso condivido le mie perplessità.
Se una persona dallo spessore culturale di Elisabetta Sgarbi sente la necessità di parlare di progresso scientifico e progresso culturale, separando la scienza dalla cultura, vuol dire che l’influenza del pensiero di Gentile secondo cui “il sapere scientifico veniva relegato nella categoria dell’utilità e nello stesso tempo gli si negava il valore di conoscenza concettuale e soprattutto di cultura” è ancora viva e vegeta.
Eppure le prime pagine dei libri di filosofia del liceo sono occupate dal pensiero dei rappresentanti della scuola di Mileto: Talete, Anassimandro e Anassimene. Nella loro ricerca del principio delle cose (l’acqua per Talete, l’apeiron o l’indefinito per Anassimandro e l’aria per Anassimene), questi Maestri facevano uso di un primordiale metodo scientifico basato sull’osservazione e sull’induzione. In altre parole, partendo dalla constatazione di certi fatti osservati (per esempio, l’acqua necessaria alla vita per Talete, l’aria che permea ogni cosa per Anassimene, oppure un insieme di fattori che Anassimandro chiama “indefinito”) questi pensatori traevano conclusioni di carattere generale sull’origine della vita e delle cose che ci circondano. E cosa dire di Democrito che, basandosi sull’osservazione che un coltello può tagliare un oggetto in pezzi sempre più piccoli fino ad un punto oltre il quale non è più possibile proseguire, introdusse il concetto di a-tomo, ovvero di indivisibile? Se vogliamo, lo stesso Aristotele può essere considerato come un precursore del moderno scienziato. Pur con le limitazioni del suo tempo, nella sua Fisica, Aristotele aveva osservato che tutto ciò che ci circonda è generato dalla combinazione di aria, acqua, terra e fuoco a cui bisogna aggiungere l’etere indispensabile per la comprensione della natura dei corpi celesti. Arrivando ad epoche più recenti, non si può non ricordare Leonardo da Vinci conosciuto non solo per le sue doti artistiche, ma anche per quelle ingegneristiche e scientifiche, oppure Göthe, appassionato di chimica, che, nelle sue “Affinità elettive“, descrive in modo sublime il concetto di affinità chimica usato ancora oggi per spiegare la formazione dei legami chimici:
“Bisogna vedere in azione davanti ai propri occhi queste sostanze all’apparenza inerti, e tuttavia intimamente sempre disposte, ed osservare con partecipazione il loro cercarsi, attirarsi, assorbirsi, distruggersi, divorarsi, consumarsi, e poi il loro riemergere dalla più intima congiunzione in forma mutata, nuova, inattesa: allora si che si deve attribuire loro un vivere eterno, anzi, addirittura intelletto e ragione, dal momento che i nostri sensi appaiono appena sufficienti ad osservarli e la nostra ragione a stento capace di interpretarli“.
Lo stesso Kant ha dedicato parte della sua opera al pensiero scientifico, così come Heisenberg , sì – proprio quello del principio di indeterminazione, ha usato la sua logica scientifica per dare un contributo alla filosofia. E cosa dire di Schöredinger che col suo “Che cos’è la vita?” ha influenzato generazioni di scienziati che, poi, hanno dato un contributo notevole allo sviluppo delle conoscenze umane (Monod, De Duve, etc)? Vogliamo parlare anche di Edward O. Wilson o di Stephen J. Gould che col loro lavoro hanno consentito di capire in che modo si sviluppano le società di esseri viventi?
Tutto questo semplicemente per dire che quello che noi identifichiamo come pensiero scientifico è in tutto e per tutto pensiero umano e, in misura più o meno variabile, contribuisce allo sviluppo culturale della comunità di cui facciamo parte. In questo senso, per cultura non intendo la conoscenza della storia, della filosofia, della letteratura o, più genericamente, l’insieme delle conoscenze puramente concettuali “sensu Gentile“, ma l’intero spettro di conoscenze che acquisiamo durante la nostra vita e trasmettiamo alle generazioni future. Che il pensiero scientifico consenta anche di produrre tecnologia e di risolvere problemi di natura tecnica è solo un dettaglio che è insito nella natura stessa di tale pensiero.