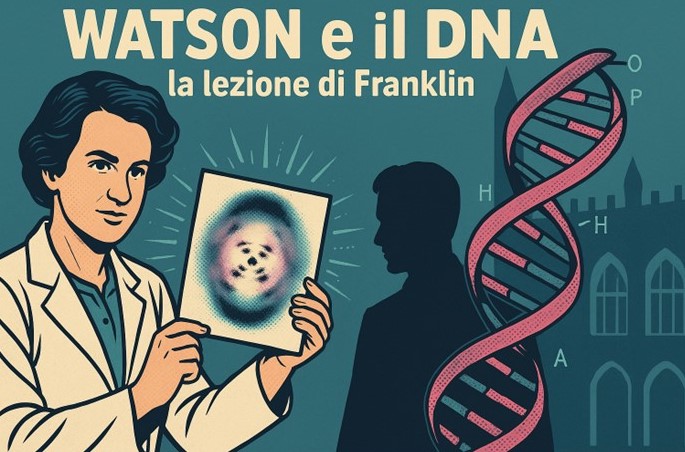Il palco di Stoccolma
L’11 dicembre 1962, James D. Watson tenne al Karolinska Institutet la sua Nobel Lecture, The involvement of RNA in the synthesis of proteins. Accanto a lui, Francis Crick e Maurice Wilkins: i tre scienziati che pochi mesi prima avevano condiviso il Premio Nobel per la Medicina per la scoperta della struttura a doppia elica del DNA..
Watson aveva trentatré anni, la brillantezza impetuosa di chi si sente al centro del mondo e la convinzione, non infondata, di aver partecipato a uno dei momenti più rivoluzionari della biologia moderna. Parlò per poco più di mezz’ora, illustrando i meccanismi di trascrizione dell’informazione genetica e il ruolo dell’RNA nella sintesi proteica. Parlò di geni, di codici, di ribosomi.
Nel suo intervento non menzionò Rosalind Franklin.
In quella sala gremita, la scienziata che aveva fornito le immagini chiave per decifrare la struttura del DNA era già scomparsa da quattro anni. Morta di cancro a 37 anni, nel 1958, non avrebbe potuto comunque ricevere il Nobel, poiché il premio non viene assegnato postumo. Ma l’assenza del suo nome — in una lezione che celebrava la vittoria della conoscenza — resta una delle omissioni più eloquenti della storia della scienza del Novecento.
La donna che guardò dentro la doppia elica
Rosalind Franklin non era un’eroina romantica né una vittima inconsapevole. Era, piuttosto, una ricercatrice di precisione chirurgica, formata tra Cambridge e Parigi, esperta di cristallografia a raggi X. Quando nel 1951 entrò al King’s College di Londra, portava con sé un bagaglio tecnico che pochi colleghi possedevano: la capacità di ottenere e interpretare immagini di strutture cristalline con un livello di dettaglio straordinario.
Fu lei a produrre la famosa “foto 51”, un’immagine di diffrazione del DNA che mostrava con chiarezza la sua struttura elicoidale. Lavorava con rigore quasi ascetico, in un ambiente accademico tutt’altro che accogliente per le donne. A quel tempo, al King’s College l’accesso agli spazi accademici era ancora fortemente segregato per genere, a riprova del clima culturale dell’epoca.
Mentre Franklin perfezionava le sue analisi, Watson e Crick — allora a Cambridge — cercavano di costruire un modello teorico della molecola. Non avevano accesso diretto ai dati sperimentali di Franklin, ma tramite Maurice Wilkins, suo collega (e, in un certo senso, suo antagonista), Watson poté vedere la famosa foto. In quella trama di macchie nere e grigie, egli riconobbe il segno inconfondibile di una doppia elica.
Da lì, la corsa si fece rapidissima. Nel numero del 25 aprile 1953 di Nature furono pubblicati tre articoli consecutivi. Il primo, firmato da Watson e Crick, presentava il modello; il secondo, da Wilkins, Stokes e Wilson lo confermava; il terzo, da Franklin e Gosling, mostrava i dati sperimentali su cui tutto poggiava. La sequenza delle pubblicazioni lasciava intendere una collaborazione armoniosa. In realtà, la comunicazione era stata minima e la tensione, altissima.
L’oblio nella Nobel Lecture
Dieci anni dopo, durante la sua Nobel Lecture, Watson non fece alcun riferimento a quella fase cruciale. Né Franklin, né la sua foto, né il suo contributo alla comprensione della struttura del DNA comparvero nel discorso.
Non fu una semplice dimenticanza. In parte, la lecture era centrata su altri temi — l’RNA e la sintesi proteica — ma la rimozione di Franklin rifletteva qualcosa di più profondo: il modo in cui la scienza istituzionale del tempo selezionava ciò che meritava memoria.
Negli anni ’50 e ’60, il merito scientifico era ancora filtrato attraverso un paradigma fortemente gerarchico e maschile. Le donne nella ricerca erano spesso viste come assistenti, non come protagoniste; la loro presenza, quando c’era, era percepita come eccezionale o marginale. In quel contesto, il nome di Franklin non fu cancellato per complotto, ma per inerzia culturale: perché era più semplice, più lineare, raccontare la scoperta come il frutto dell’intuizione di due giovani geni di Cambridge.
La riscrittura di una storia
Nel 1968, sei anni dopo la Nobel Lecture, James Watson pubblicò The Double Helix. Il libro, presentato come un “racconto personale della scoperta del DNA”, fu un successo editoriale immediato — ma anche una tempesta.
Watson vi raccontava la vicenda come una corsa intellettuale punteggiata da intuizioni, errori e colpi di fortuna. Il tono era brillante, ironico, spesso spregiudicato. Ma il ritratto di Rosalind Franklin appariva distorto: la chiamava “Rosy”, un nomignolo che lei non usava; la descriveva come “poco femminile”, “irascibile”, “ostinata”.
Solo nelle ultime pagine, quasi di sfuggita, Watson riconosceva che i suoi dati erano stati “cruciali” per la costruzione del modello della doppia elica.
Il libro provocò una reazione immediata. Anne Sayre, amica e collega di Franklin, pubblicò nel 1975 Rosalind Franklin and DNA, un testo scritto per “restituire equilibrio” a una storia che era stata piegata al punto di vista maschile e competitivo di Watson. In seguito, biografi come Horace Freeland Judson e Brenda Maddox avrebbero contribuito a una rilettura più accurata e documentata del ruolo di Franklin.
Da allora, la sua figura è uscita dall’ombra per entrare nel pantheon — non come martire della scienza, ma come simbolo della precisione, della pazienza e dell’intelligenza metodica che completano l’intuizione geniale.
Watson dopo Watson
Col passare degli anni, Watson rilesse più volte il proprio operato. In interviste successive, Watson ha più volte riconosciuto l’importanza decisiva dei dati di Franklin.
In altre occasioni definì The Double Helix un resoconto personale, non pensato come ricostruzione storica. In pratica, un racconto soggettivo di un giovane scienziato più attento alla competizione che alla sensibilità.
Tuttavia, la sua figura pubblica continuò a essere controversa. Le sue dichiarazioni successive su razza, intelligenza e genetica provocarono dure critiche, fino alla revoca di onorificenze e incarichi. È ironico — e forse istruttivo — che l’uomo che aiutò a svelare la struttura molecolare della vita sia diventato, nella memoria collettiva, un esempio di quanto la conoscenza possa coesistere con il pregiudizio.
Il contesto: scienza, società e invisibilità
Per comprendere davvero il “silenzio” di Watson, bisogna tornare al mondo della scienza degli anni ’50.
Il dopoguerra aveva accelerato la trasformazione dei laboratori in istituzioni competitive, legate ai finanziamenti pubblici e all’industria. Il linguaggio scientifico si era fatto più aggressivo, quasi darwiniano: vincere significava pubblicare per primi, ottenere riconoscimento, attrarre risorse.
In questo clima, le dinamiche di genere erano una componente implicita ma potente. Le donne rappresentavano una minoranza esigua nei dipartimenti scientifici; raramente avevano posizioni indipendenti, e spesso il loro lavoro veniva attribuito ai supervisori maschi.
Rosalind Franklin non fu un’eccezione: fu una scienziata che osò comportarsi da pari in un mondo che la voleva subordinata. La sua intransigenza, spesso percepita come freddezza, era una forma di autodifesa in un ambiente che tollerava la competenza femminile solo se accompagnata da deferenza.
Eppure, quella stessa intransigenza è ciò che le permise di ottenere risultati di una precisione senza precedenti. In un certo senso, la sua vicenda mostra il paradosso della scienza moderna: un sistema che premia la razionalità ma è plasmato da pregiudizi irrazionali.
Il tempo della memoria
Oggi, la storia di Rosalind Franklin è raccontata nei musei, nei documentari, nelle aule universitarie. È diventata una figura di riferimento per le donne nella scienza, ma anche un simbolo più ampio: quello della necessità di una memoria scientifica capace di riconoscere i contributi oltre i miti.
La sua immagine — austera, concentrata, quasi imperscrutabile — contrasta con il tono leggero e competitivo con cui Watson e Crick raccontarono la loro impresa. Ma proprio in quella differenza risiede la lezione più profonda: la scienza non è solo un gioco di intuizioni geniali, è anche una costruzione lenta, fatta di rigore, di dubbi, di dedizione quotidiana.
Se oggi conosciamo la struttura del DNA, lo dobbiamo a entrambe le forze: all’immaginazione teorica e alla precisione sperimentale. La storia della doppia elica non è il trionfo di due uomini o la rivincita di una donna: è un intreccio di caratteri, talenti e tempi, come le due spirali del DNA stesso.
Scienza e imperfezione umana
C’è però un altro piano, più sottile, che questa vicenda invita a considerare: il rapporto tra grandezza scientifica e imperfezione umana.
Watson, con le sue omissioni e i suoi pregiudizi, non smette per questo di essere uno dei protagonisti della biologia del Novecento. E la stessa cosa vale, su altri piani, per figure come Fritz Haber, Albert Einstein o Erwin Schrödinger: uomini di ingegno straordinario ma di condotta spesso discutibile.
Haber sviluppò la reazione che porta il suo nome, permettendo la produzione di ammoniaca e, di conseguenza, la rivoluzione dei fertilizzanti sintetici. Ma fu anche l’uomo che coordinò l’uso dei gas tossici nella Prima guerra mondiale.
Einstein lasciò la prima moglie in condizioni economiche precarie e mostrò poca sensibilità nelle relazioni familiari, ma la sua teoria della relatività cambiò per sempre il nostro modo di concepire lo spazio e il tempo.
Schrödinger, genio della meccanica quantistica, visse relazioni extraconiugali palesi che scandalizzarono i suoi contemporanei.
Tutti e tre — come Watson stesso — incarnano una verità scomoda ma necessaria: la scienza non redime l’uomo, e l’uomo non deve redimere la scienza. Il valore di una scoperta non dipende dalla moralità del suo autore, così come la condotta personale non può cancellare un risultato scientifico.
Ciò che invece possiamo — e dobbiamo — chiedere è una memoria onesta, che riconosca la complessità senza mitizzare né demonizzare.
Parallelismi contemporanei
Nel mondo della ricerca di oggi, le dinamiche di potere e visibilità non sono scomparse: si sono trasformate.
Le barriere di genere si sono ridotte ma non dissolte; la competizione per la pubblicazione e il finanziamento è ancora feroce; l’autorialità collettiva rende più difficile distinguere i contributi individuali.
Le “Rosalind Franklin” contemporanee sono spesso giovani ricercatrici o ricercatori precari, che lavorano dietro le quinte di grandi progetti, i cui nomi scompaiono nelle appendici delle supplementary materials.
Eppure, qualcosa è cambiato: oggi la comunità scientifica è più consapevole del valore della diversità e della necessità di riconoscere i meriti in modo più equo. La storia di Franklin è diventata un monito e un modello, ricordando che la scienza è tanto più solida quanto più ampie sono le voci che la costruiscono.
Conclusione – La doppia elica della memoria
Il silenzio di Watson, nella Nobel Lecture del 1962, non è solo un fatto storico: è una metafora della memoria selettiva con cui la scienza, come ogni impresa umana, racconta se stessa.
Ma la memoria, come il DNA, può essere riscritta. Negli anni, le spirali dell’oblio e del riconoscimento si sono avvolte e sciolte più volte, fino a ricomporre un quadro più giusto.
Oggi ricordiamo Rosalind Franklin non per la sua marginalizzazione, ma per il suo rigore, la sua lucidità, la sua capacità di vedere ciò che altri non seppero guardare.
E forse è questa la vera eredità della sua storia: riconoscere che la scienza vive della tensione fra verità e umanità, fra il desiderio di conoscere e le debolezze di chi conosce.
Watson, Crick, Franklin, Wilkins: quattro nomi intrecciati come le due catene della doppia elica. Nessuno di loro perfetto, ma tutti parte di una stessa sequenza di scoperte, errori, intuizioni e silenzi.
La scienza — come la vita — non è mai lineare. È una spirale che, pur nascendo dall’imperfezione, continua a replicarsi nel tempo.
Riferimenti e fonti principali
- Cobb, M. (2015). Sexism in science: did Watson and Crick really steal Rosalind Franklin’s data? The Guardian
- Cobb, M., Comfort, N. (2023). What Rosalind Franklin truly contributed to the discovery of DNA’s structure. Nature, 616: 657-660
- Franklin, R.E., Gosling, R.G. (1953). Molecular Configuration in Sodium Thymonucleate. Nature, 171: 740–741.
- Judson, H.F. (1979). The Eighth Day of Creation: Makers of the Revolution in Biology. Simon & Schuster.
- Maddox, B. (2002). Rosalind Franklin: The Dark Lady of DNA. HarperCollins.
- Sayre, A. (1975). Rosalind Franklin and DNA. W.W. Norton.
- Watson, J.D. (1962). The involvement of RNA in the synthesis of proteins. Nobel Lecture. NobelPrize.org
- Watson, J.D. (1968). The Double Helix: A Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA. Atheneum.
- Watson, J.D. (with Andrew Berry) (2003). DNA. The secret of life. Alfred A. Knopf, NY
- Wilkins, M.H.F., Stokes, A.R., Wilson, H.R. (1953). Molecular Structure of Deoxypentose Nucleic Acids. Nature, 171: 738–740.