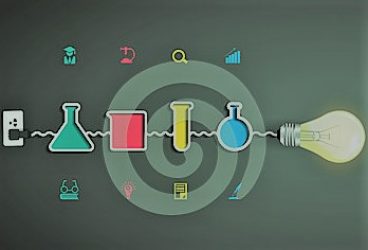Chiunque navighi un po’ sui social sa che prima o poi finirà per imbattersi in una teoria del complotto. Le scie chimiche, il 5G, i vaccini, società segrete che tirerebbero i fili del mondo: racconti affascinanti che spesso viaggiano più veloci delle notizie verificate. A volte fanno sorridere, altre volte mettono i brividi. Ma il punto interessante è un altro: perché sembrano così attraenti? E perché, nonostante viviamo nell’epoca della massima disponibilità di informazioni, hanno tanto successo?
Che cos’è una teoria del complotto
Una teoria del complotto non è semplicemente un sospetto o un dubbio legittimo. È un racconto strutturato, che propone una spiegazione alternativa di eventi complessi attribuendone la responsabilità a un gruppo ristretto e potente che agirebbe nell’ombra. In sé, l’idea di complotto non è assurda: la storia è piena di trame segrete e accordi illeciti che hanno avuto un impatto reale. Basti pensare al Watergate negli Stati Uniti o a Tangentopoli in Italia, episodi che hanno mostrato come politici e imprenditori possano effettivamente cospirare per i propri interessi.
La differenza fondamentale tra un complotto reale e una teoria complottista sta nelle prove. Nel primo caso disponiamo di documenti, testimonianze, indagini giornalistiche e processi che permettono di ricostruire i fatti. Nel secondo, invece, le “prove” sono spesso vaghe: interpretazioni arbitrarie o coincidenze cucite insieme in un’unica trama.
Come si è visto, nella nostra lingua il termine complotto viene usato in entrambi i sensi, generando ambiguità. Una distinzione più chiara sarebbe parlare di cospirazione quando ci riferiamo a eventi storici reali e documentati, e riservare l’espressione teoria del complotto ai racconti speculativi privi di fondamento.
Indipendentemente dal lessico scelto, resta il fatto che il fascino delle teorie complottiste non nasce dalla loro solidità logica, ma dalla loro capacità di trasformare frammenti sparsi in storie suggestive e coinvolgenti.
Psicologia dei complotti: perché ci crediamo
Molti studiosi hanno mostrato come le teorie del complotto facciano leva su meccanismi profondi della nostra mente. Uno dei più radicati è la tendenza a riconoscere schemi anche dove non ci sono: è ciò che lo psicologo Michael Shermer ha chiamato patternicity. Collegare eventi casuali in una trama coerente ci dà l’impressione di capire meglio il mondo, anche quando in realtà stiamo solo costruendo connessioni inesistenti.
A questo si aggiunge il cosiddetto confirmation bias, il pregiudizio di conferma: una volta che abbiamo un’idea in testa, siamo portati a cercare solo le informazioni che la confermano, scartando quelle che la contraddicono. È un meccanismo che funziona inconsciamente e che rende molto difficile cambiare opinione. E non riguarda solo le persone comuni: anche scienziati illustri vi sono caduti. Linus Pauling, due volte premio Nobel, rimase convinto per decenni che la vitamina C fosse una sorta di rimedio universale, nonostante le evidenze contrarie. Luc Montagnier, scopritore del virus HIV, ha sposato in tarda carriera teorie prive di fondamento come la “memoria dell’acqua”. Perfino James Watson, co-scopritore del DNA, ha difeso posizioni discutibili sull’intelligenza e la genetica. Sono esempi che mostrano come il fascino delle proprie idee possa resistere ai dati più solidi.
Non bisogna poi dimenticare un altro aspetto fondamentale: le teorie del complotto rispondono a un bisogno psicologico di controllo. Eventi grandi e imprevedibili – come una pandemia o una crisi economica – possono generare ansia e senso di impotenza. Pensare che ci sia qualcuno “dietro le quinte” che orchestra tutto può sembrare paradossalmente più rassicurante che accettare la realtà caotica e complessa. Infine, c’è il fascino della narrazione: un complotto è, in fondo, una storia. Ha i suoi eroi, i suoi nemici, i suoi colpi di scena. E spesso, dal punto di vista narrativo, è molto più attraente della verità semplice e disordinata.
Quando sapere poco sembra sapere tanto
Un altro ingrediente che contribuisce al successo dei complotti è quello che gli psicologi David Dunning e Justin Kruger hanno descritto ormai più di vent’anni fa: il cosiddetto effetto Dunning-Kruger. Si tratta della tendenza, molto diffusa, delle persone con competenze limitate a sopravvalutare le proprie conoscenze. Chi conosce poco un argomento non ha gli strumenti per valutare la propria ignoranza e finisce per sentirsi molto più competente di quanto sia.
Sui social media questo fenomeno è evidente: chi non ha una formazione scientifica solida può mostrarsi estremamente sicuro di “aver capito” meccanismi complessi che, in realtà, studiosi con anni di esperienza trattano con cautela. È la paradossale sicurezza di chi sa poco, contrapposta al dubbio metodico di chi sa di più.
Accanto a questo, esiste un problema culturale più ampio: il cosiddetto analfabetismo di ritorno. Non significa non saper leggere o scrivere, ma non essere in grado di comprendere testi complessi, grafici, numeri, concetti logici. È un fenomeno documentato anche nei Paesi sviluppati: molte persone diplomate o laureate hanno difficoltà a interpretare correttamente un articolo scientifico o un’informazione statistica. Questo rende più facile affidarsi a slogan semplici, a video emozionali o a frasi ad effetto che non richiedono uno sforzo di analisi.
Quando la sovrastima di sé si unisce alla scarsa comprensione dei contenuti complessi, il terreno è fertile per i complotti. Una spiegazione semplice, anche se sbagliata, risulta più convincente di una realtà intricata che richiede studio e pazienza per essere compresa.
Il megafono dei social media
I social media non hanno inventato i complotti, ma li hanno resi virali come mai prima d’ora. Gli algoritmi che regolano la visibilità dei contenuti tendono a premiare ciò che suscita emozioni forti: indignazione, paura, rabbia. E poche cose funzionano meglio di una buona teoria del complotto.
Così, una voce marginale può crescere rapidamente fino a diventare un fenomeno di massa. Le comunità online che si formano intorno a queste narrazioni funzionano come camere dell’eco: chi ne fa parte trova continuamente conferme, rafforzando la propria convinzione e allontanandosi progressivamente da fonti alternative. L’effetto è quello di una polarizzazione crescente, dove chi prova a introdurre dubbi o dati correttivi viene percepito come un nemico o un ingenuo “complice del sistema”.
Quando il complotto diventa pericoloso
Le teorie del complotto non sono soltanto curiosità folkloristiche della rete: possono avere conseguenze molto concrete e spesso gravi. Un esempio evidente lo abbiamo vissuto durante la pandemia di COVID-19: la diffusione di narrazioni false sui vaccini o sull’origine del virus ha alimentato paure irrazionali, rallentato le campagne di prevenzione e, in alcuni casi, messo a rischio la salute pubblica. Ma non si tratta solo di medicina.
I complotti possono minare la fiducia nelle istituzioni democratiche, spingere le persone a rifiutare dati scientifici fondamentali – come quelli sul cambiamento climatico – e perfino fomentare conflitti sociali. Non mancano esempi in cui comunità online complottiste hanno alimentato forme di odio, radicalizzazione e violenza. In fondo, ogni complotto funziona un po’ come una lente distorta: divide il mondo in “noi” e “loro”, i pochi illuminati contro i tanti manipolati, creando una frattura che si allarga nella società reale.
La pericolosità sociale delle teorie del complotto sta proprio qui: non solo diffondono disinformazione, ma indeboliscono il tessuto di fiducia reciproca su cui si reggono le comunità. Il movimento QAnon, ad esempio, ha eroso la fiducia nelle istituzioni democratiche fino a culminare nell’assalto al Campidoglio; le false narrazioni sul cambiamento climatico hanno rallentato le politiche di mitigazione globale; durante l’epidemia di Ebola in Africa occidentale, i complotti sulla presunta origine artificiale del virus portarono a diffidenza e ostilità verso le squadre mediche. Senza fiducia, diventa molto più difficile collaborare, prendere decisioni condivise, affrontare sfide collettive.
Un problema epistemologico: critica o sfiducia?
A questo punto, il discorso si sposta su un piano più profondo: quello epistemologico, cioè del modo in cui costruiamo e valutiamo la conoscenza. Qui il pensiero di Evandro Agazzi, filosofo della scienza che ha riflettuto molto sul rapporto tra razionalità e verità, può essere illuminante. Agazzi distingue tra razionalità critica e sfiducia generalizzata.
La razionalità critica è l’atteggiamento che dovrebbe guidare ogni scienziato: dubitare, verificare, controllare le fonti. È un esercizio sano, indispensabile, che permette di correggere errori e migliorare le nostre conoscenze. La sfiducia generalizzata, invece, è un atteggiamento diverso: non è un dubbio metodico, ma un rifiuto sistematico di qualunque autorità o dato ufficiale. È l’idea che tutto ciò che viene dalle istituzioni, dagli esperti, dai ricercatori sia per definizione falso o manipolato.
La differenza è sottile, ma decisiva. La scienza vive della prima, mentre le teorie complottiste prosperano sulla seconda. In altre parole, non è lo spirito critico a generare complotti, ma la sua caricatura: una sfiducia cieca che porta a credere solo a ciò che si adatta al proprio pregiudizio.
Conclusione: la verità è meno spettacolare, ma più solida
Ridicolizzare chi crede ai complotti è una tentazione comprensibile, ma spesso controproducente. Le persone finiscono per sentirsi attaccate e si rifugiano ancora di più nelle proprie convinzioni. È più utile capire i meccanismi che portano a credere in certe narrazioni e proporre alternative: una buona educazione al pensiero critico, la capacità di distinguere tra scetticismo sano e sfiducia totale, la diffusione di una cultura scientifica accessibile ma rigorosa.
La verità, ammettiamolo, non avrà mai il fascino di un grande intrigo segreto: non promette trame lineari né colpi di scena spettacolari. È frammentaria, complessa, a volte persino noiosa. Ma ha un vantaggio che nessun complotto inventato può vantare: resiste al tempo. L’ombra seducente dei complotti svanisce alla luce dei fatti, e alla lunga, è sempre quella luce a illuminare la strada.